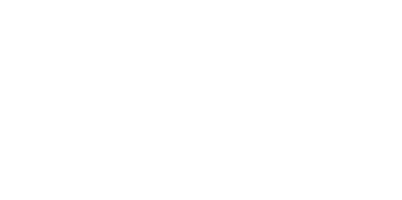Sulla possibile qualificazione “retributiva” dei trattamenti previdenziali e le sue implicazioni: il peculiare caso del TFR a carico del Fondo di Tesoreria dell’INPS

di Francesco Marasco
Nel prendere le mosse da un problema qualificatorio del TFR dovuto dal Fondo di Tesoreria, su cui il Supremo Collegio è stato recentemente chiamato a pronunciarsi (Cass., Sez. Lav., n. 10082/2025, rel. Riverso), si espongono alcune riflessioni in merito alla configurabilità dei trattamenti previdenziali spettanti al lavoratore alla stregua “retribuzione differita”, anche alla luce di una recente ordinanza del Tribunale di Napoli (31.03.2025, est. Coppola).
1. Inesistenza di un “diritto alla regolarizzazione” della posizione contributiva del lavoratore dipendente: un’aporia (forse) irrimediabile dell’ordinamento previdenziale italiano.
Costituisce principio ormai recetto nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui nell’ordinamento previdenziale italiano, mentre è configurabile “un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali” da parte del datore di lavoro (trovando tale diritto espressione nell’azione risarcitoria contemplata dall’art. 2116, comma 2, c.c.: cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del 1° febbraio 2021, n. 2164), non è in alcun modo contemplata “un’azione dell’assicurato volta ad ottenere la condanna dell’ente previdenziale alla “regolarizzazione” della sua posizione contributiva” (così, lapidariamente, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza dell’11 settembre 2023, n. 26248).
Ciò, stando alla menzionata giurisprudenza di legittimità, neppure “nell’ipotesi in cui l’ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell’inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l’adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato” (sic, Cass., n. 26248/2023, cit.). In tali casi, semmai, residuerebbe al lavoratore dipendente “la facoltà di chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13”, secondo quanto sancito dell’orientamento testé citato.
Quanto sopra, s’intende, salvo l’eventuale decorso del termine prescrizionale entro il quale esperire la suesposta azione, sul cui dies a quo si attende una pronuncia a opera del Supremo Collegio a Sezioni Unite (la Sezione remittente propende per la “data in cui matura il danno di cui all’art. 2116 comma 2° c.c.”: così, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza interlocutoria del 14 maggio 2024, n. 13229, rel. Cavallaro).
Termine, questo, cui si aggiunge anche quello quinquennale previsto in generale per l’esazione dei contributi (v. art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995), avente efficacia immediatamente estintiva rispetto alla prestazione che si intende far valere (cfr., di recente, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza dell’8 novembre 2024, n. 28821); circostanza che diventa particolarmente rilevante nei casi in cui, oltre a essere divenuti irripetibili i contributi previdenziali, il lavoratore non possa beneficiare di alcun rimedio risarcitorio nei confronti del datore di lavoro, ad esempio perché divenuto insolvente.
Ed è proprio un caso di tal genere che ha spinto il Supremo Collegio e una certa giurisprudenza di merito a interrogarsi circa la possibilità di qualificare le prestazioni a carico dell’INPS in ottica “retributiva” e non già prettamente previdenziale, con conseguente differimento di ogni termine prescrizionale a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Un caso particolare: la natura (anche) retributiva del TFR a carico del Fondo di Tesoreria dell’INPS.
Segnatamente, tale qualificazione è stata da ultimo esplorata con l’ordinanza n. 10082 del 16 aprile 2025 della Suprema Corte di Cassazione e con riferimento al TFR a carico del Fondo di Tesoreria dell’INPS.
Per chiarire il tema oggetto di indagine, giova prendere le mosse da un precedente arresto della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza del 25 agosto 2023, n. 25305), a mente del quale il suddetto Fondo è gravato di null’altro che una “prestazione previdenziale”.
Questo in ragione della peculiare conformazione conferita al Fondo di Tesoreria per effetto della Legge n. 296/2006 e dei commi 756 e ss. dell’art. 1, secondo cui “la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”: di conseguenza, come sancito dalla sentenza n. 25305/2023 del Supremo Collegio, “il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1°.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria”.
Ed invece, il più recente arresto rappresentato dall’ordinanza n. 10082/2025 propende per la soluzione secondo cui, pur nel composito panorama normativo delineato dalla Legge n. 296/2006, il TFR a carico del Fondo di Tesoreria mantiene intatta la sua natura retributiva: invero, a detta del Supremo Collegio, pare indubbio che le quote da accantonare a tale scopo siano “intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina l’esigibilità”.
Né in senso contrario può militare il richiamo al meccanismo di tipo latamente “contributivo” con cui il Fondo di Tesoreria dovrebbe essere finanziato, posto che “in caso di inadempimento” da parte del datore di lavoro non si produce “alcuna automatica immutazione della natura sostanziale del TFR, intesa come retribuzione differita ex art. 2120 c.c.; né tale richiamo incide sulla modalità di calcolo delle suddette quote e della relativa base imponibile, che restando regolata dall’art. 2120 c.c. è diversa da quella propria dei contributi previdenziali”.
Si badi bene: dietro la dotta disquisizione dei Giudici di legittimità si cela un problema estremamente pragmatico e che nella fattispecie concreta esaminata – incentrata sul diniego di liquidazione integrale del TFR opposto dall’INPS a un lavoratore – avrebbe avuto una portata devastante, ossia la prescrizione della stessa prestazione fatta valere. Difatti, come la Suprema Corte ha affermato a chiare lettere nel provvedimento qui annotato, “se si negasse la concomitante natura retributiva del TFR regolato dalla legge n. 296/2006 e si affermasse l’esclusiva natura previdenziale delle somme dovute, anche nell’ipotesi in cui le quote di TFR non fossero state versate (come capita frequentemente in caso di insolvenza del datore e come è comprovato anche dal caso in esame), lo stesso lavoratore, come quello qui ricorrente, subirebbe inevitabilmente la falcidia della prescrizione (dei c.d. contributi, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità; v. Cass. n. 31282 del 29/11/2019), senza alcuna automaticità della sua prestazione ex art. 2116 c.c.”.
In altri termini, la qualificazione strettamente previdenziale del TFR erogato dal Fondo di Tesoreria implica, quale naturale conseguenza, che i contributi destinati a foraggiare tale prestazione siano soggetti a una prescrizione quinquennale, decorrente nel corso del rapporto di lavoro e di difficile interruzione (v. infra); di contro, l’inquadramento retributivo di quel TFR fa sì che la decorrenza del relativo termine prescrizionale cominci solo a rapporto di lavoro cessato.
Ma, rebus sic stantibus, considerato che il problema della prescrizione dei “contributi” destinati al Fondo di Tesoreria dell’INPS è il medesimo che connota ogni altra prestazione pensionistica, sarebbe forse possibile ancorare il decorso del termine prescrizionale anche di tali contributi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro? La risposta affermativa presuppone una preliminare qualificazione in ottica retributiva delle stesse prestazioni pensionistiche.
3. Un tema generale: la natura (verosimilmente) retributiva dei trattamenti pensionistici computati sulla scorta di emolumenti retributivi.
Giungiamo, così e per gradi, alla disamina di un altro, non meno interessante, precedente reso dalla giurisprudenza di merito in termini assonanti con quelli dianzi ripercorsi: trattasi, precisamente, dell’ordinanza del 31 marzo 2025 del Tribunale di Napoli.
Questa, in sintesi, la fattispecie concreta posta all’attenzione del Giudice partenopeo: un lavoratore aveva chiesto e ottenuto la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’effettivo datore, e ciò a far tempo dal 2003; a decorrere dallo stesso periodo, e sino al dicembre 2015, il medesimo aveva domandato la regolarizzazione della propria posizione contributiva, peraltro impedita dal fatto che, medio tempore, i relativi contributi previdenziali si erano prescritti.
In tale contesto si innestano le considerazioni svolte nel citato provvedimento, onde verificare la compatibilità dell’impianto legislativo sotteso all’erogazione delle prestazioni pensionistiche con la necessità di garantire un’effettiva tutela dei diritti ai sensi della “direttiva 91/533/Cee, poi direttiva 2019/1152”: “gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie per consentire a qualsiasi lavoratore che si ritenga leso dalla mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva di difendere i propri diritti per via legale dopo aver fatto eventualmente ricorso ad altri organi competenti” (v. art. 8, Direttiva 91/553; analogamente e oggi, art. 16 della Direttiva 2019/1152).
Precisamente, le considerazioni del Giudice monocratico muovono dal fatto che, stando a una certa giurisprudenza europea, i c.d. “sistemi previdenziali professionali” e le prestazioni a essi riconducibili assumono natura retributiva: a tal fine, è richiesto che (i) il regime interessi una particolare categoria di lavoratori; (ii) le somme versate dopo il pensionamento siano correlate agli anni di servizio; (iii) le prestazioni da erogare siano calcolate in base alla retribuzione percepita per le ultime funzioni esercitate.
Orbene, vero è che la giurisprudenza europea ripercorsa nel provvedimento in commento ha riconosciuto la natura retributiva a prestazioni come la “pensione ai superstiti” (C-267/2006, sentenza del 1° aprile 2008, “Maruko”), pur dando concomitante rilievo all’esistenza di un contratto collettivo che disciplinava l’istituzione della prestazione in commento (nella fattispecie trattasi del contratto collettivo dei lavoratori teatrali in Germania) e il suo meccanismo di approvvigionamento (alla cui contribuzione avrebbero dovuto provvedere sia il datore di lavoro che il lavoratore), nonché alla circostanza che l’importo della prestazione era “calcolato in base all’ultima retribuzione”.
Per modo che non parrebbe esservi alcun dubbio sulla natura retributiva di prestazioni erogate a carico di fondi di previdenza complementare (v. C-147/1995, sentenza del 17 aprile 1997, “Evrenopolus”), con qualche spiraglio – pur non senza riserve – anche per i trattamenti pensionistici calcolati con il sistema retributivo, posto che il metodo di computo contempla la media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa (analoga apertura potrebbe, pertanto, valere anche per i sistemi “misti”, ossia in parte retributivo e in parte contributivo).
Vero è anche che la suesposta giurisprudenza europea non ha mai dato alcun ruolo decisivo al “carattere obbligatorio dell’iscrizione al regime che dà diritto alla prestazione” o alla “qualità di ente pubblico” dell’ente erogatore (C-267/2006). Sicché, si potrebbe forse propendere – almeno in teoria e fermi gli altri requisiti dianzi esposti – per un’impostazione “retributiva” anche delle prestazioni pensionistiche a carico dell’INPS, chiamato oggi ad amministrare 55 gestioni previdenziali e assistenziali aventi ciascuna la propria autonomia contabile ed economica (fonte: Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS – La natura delle entrate e uscite dell’INPS); invero, in relazione ai trattamenti gravanti sull’INPS solo una parte contempla il concorso dello Stato (arg. ex art. 37, comma 3, L. n. 88/1989).
Da qui, in sintesi, l’interrogazione del Giudice partenopeo rivolta direttamente alla Corte Europea di giustizia, mediante rinvio ai sensi dell’art. 19 del Trattato sull’Unione Europea dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in merito – tra l’altro, anche – a ciò che “se la pensione … dipendendo dalla contribuzione versata proporzionale alla retribuzione goduta ed agli anni di iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria costituisca, per gli iscritti del settore privato, retribuzione differita ai sensi dell’art. 2 della direttiva 91/533/Cee”.
4. Le possibili implicazioni derivanti da un’impostazione retributiva dei trattamenti pensionistici, ovvero sul necessario approntamento di una soluzione secondo “buon senso”.
Evidente, però, come una simile conclusione abbia un impatto tutt’altro che trascurabile sull’ordinamento previdenziale. Ed infatti, pur ammettendosi che i bilanci dell’INPS siano in positivo (come recentemente affermato dal suo Presidente) e che la gestione pensionistica è separata da quella assistenziale (vedendo, quest’ultima, una sempre più crescente domanda), l’interpretazione dei trattamenti pensionistici in ottica retributiva comporta una drastica revisione dell’autonomia del rapporto previdenziale, creando una non trascurabile “confusione” tra l’obbligazione previdenziale e quella tout court retributiva.
E ciò con parimenti, non trascurabili, possibili riflessi sul piano pratico: invero, la radicale assimilazione tra le due obbligazioni, al netto della specificità degli interessi che le sorreggono (anche di bilancio, nel caso delle prestazioni pensionistiche), potrebbe magari aprire la strada a che anche con riferimento alla prestazione previdenziale valgano le medesime eccezioni opponibili con riguardo alle retribuzioni. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2955 c.c. con riguardo alla tredicesima: ammettendo la natura retributiva sia della tredicesima che dei contributi a essa relativi, ciò dovrebbe comportare che l’INPS sia ammesso a eccepire una prescrizione annuale a fronte di quella quinquennale, che è quella prevista per i contributi previdenziali in generale (pur con tutti i limiti della prescrizione presuntiva: cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza dell’11 luglio 2023, n. 19649).
Ciononostante, sembrerebbe che i potenziali svantaggi sottesi all’assimilazione retributiva delle pensioni siano inferiori ai potenziali vantaggi: su tutti primeggia, come evidenziato dal Tribunale di Napoli, la necessità di fronteggiare quel “metus sussiste per le richieste di pagamento delle retribuzioni, che costituiscono un bene di cui il lavoratore godrebbe subito” che ha un effetto “ben maggiore … per i contributi che influiscono sul diritto a pensione che potrà ottenere solo al momento della maturazione del diritto a pensione”.
A ben vedere, dunque, l’ordinanza del 31 marzo 2025 del Tribunale di Napoli non fa altro che collocarsi nella medesima scia espansiva già delineata da Cass. Civ., Sez. Lav., n. 26246/2022, con riguardo alla decorrenza del regime prescrizionale dei diritti patrimoniali dei lavoratori solo a rapporto di lavoro cessato, e che il medesimo Supremo Collegio ha dimostrato di poter applicare, giusta pronuncia n. 10082/2025, anche con riguardo al TFR del Fondo di Tesoreria.
Ciò, peraltro, anche a costo di operare un “ibrido” giuridico delle prestazioni in commento, che finiscono per assumere, al contempo e di fatto, natura previdenziale e retributiva. Ibrido che, nondimeno, parrebbe già essere stato avallato dallo stesso INPS allorquando, con Circolare n. 70/2023, arriva ad ammettere – a talune condizioni – che “la domanda di intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982 può essere accolta per la parte di TFR non esposta nel conto del Fondo di tesoreria”, operando così una commistione tra due prestazioni ontologicamente diverse tra loro.
Insomma, la tutela dei diritti dei lavoratori sembra costituire il fine da perseguire a ogni costo, ricercando a posteriori le soluzioni tecnico-giuridiche che dovrebbero avallarlo. Operazione, questa, particolarmente ambiziosa ma che, in ottica sistemica, non può mai prescindere dal corretto inquadramento degli istituti di legge, pena l’incrinatura del sistema stesso.
Alla Corte Europea di giustizia, dunque, il compito di chiarire se è vero che “il fine [n.d.r.: la liberazione dal bisogno] giustifica i mezzi”. Il tutto, si auspica, seguendo anche il “buon senso”.