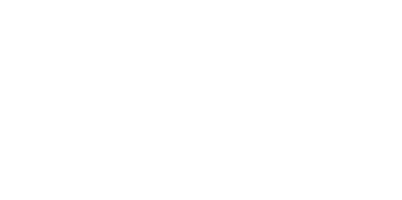La durata del periodo di prova nei contratti a termine, tra favor praestatoris, lettera della legge e ratio dell’istituto

di Massimo Cundari
La circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 27 marzo 2025 che, nel fornire prime indicazioni operative sulle disposizioni in materia di lavoro della legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro) si occupa, tra l’altro, della norma (art. 13 di tale provvedimento legislativo) che riguarda la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, offre l’occasione per sviluppare qualche riflessione sulla lettura di tale nuova disposizione offerta dal Dicastero e, più in generale, sull’intera disciplina di tale materia[1].
Il periodo di prova nei contratti a termine prima del c.d. Decreto Trasparenza
Con il provvedimento in commento, il Legislatore è intervenuto a modificare il testo dell’art. 7 del D.Lgs. n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza) che, appunto, tra l’altro, ha anche introdotto una specifica regolamentazione della durata del periodo di prova nei contratti a termine.
Prima di tale intervento, non vi era infatti alcuna norma di legge che differenziasse, quanto a durata, il periodo di prova, a seconda che lo stesso fosse collocato all’interno di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
A dire il vero, prima di tale disposizione, che, ora, in generale, fissa in sei mesi la durata massima del periodo di prova, se si eccettua quanto previsto dalla risalente legge sull’impiego privato (art. 4 R.D.L. n. 1825/1924, che comunque, per questa parte, poteva ritenersi ancora del tutto attuale e valida[2]), ed in alcuni contratti collettivi legificati mediante il procedimento di cui alla legge Vigorelli (n. 741/1959), non vi era proprio una specifica norma di legge che fissasse una durata precisa del periodo di prova.
L’art. 2096 c.c., ovviamente da contestualizzare in un sistema che (originariamente) già conteneva le norme sull’impiego privato di cui si è detto, a cui si aggiungevano le previsioni specifiche dei contratti corporativi, obbligate a fissare una durata al periodo di prova[3], si limita(va) a fissare solo delle norme-principio di carattere generale; stabilendo, per quanto qui rileva, che “l’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova”. E che “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine”.
Spostando lo sguardo alla disciplina post-corporativa (fatte salve le previsioni necessariamente solo settoriali contenute nei ccnl legificati di cui si è detto), l’estensione massima legale del periodo di provaveniva per lo più semplicemente desunta dalla previsione della Legge n. 604/1966 (art. 10), che stabilisce che le norme (da essa recate) in materia di giustificatezza del licenziamento, per i lavoratori assunti in prova, si applicano (solo) dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando siano decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro[4].
In questa situazione è stata soprattutto la contrattazione collettiva di diritto comune a farsi carico di stabilire dei termini di durata al periodo di prova. Ciò è accaduto per lo più mediante una graduazione della sua misura che, nel rispetto del tetto massimo di sei mesi, ha utilizzato come unico parametro il livello di inquadramento dei lavoratori. La durata è stata quindi determinata in modo direttamente proporzionale al livello di inquadramento, secondo una equazione così sintetizzabile: livello superiore=maggiore complessità delle mansioni=necessità di un (mutuando la terminologia dell’art. 2096 c.c.) esperimento più lungo. E va evidenziato come, nel fare ciò, le parti contrattuali non si siano sostanzialmente preoccupate di graduare la durata della prova anche in funzione della durata del contratto sottostante. Evidentemente ritenendo che la durata del rapporto nel quale collocarla, di per sé, a parità di mansioni, non potesse comunque comportare una modifica della funzione della prova e, conseguentemente, della sua estensione temporale.
Del resto, nonostante in dottrina si fosse prospettata la necessità di tenere conto, nella determinazione della durata della prova, di un suo riproporzionamento in caso di suo inserimento in un contratto a termine[5], la giurisprudenza, in assenza di una norma ad hoc, escludeva che l’applicazione in tali contratti, di una prova di durata analoga a quella prevista per il tempo indeterminato, fosse illegittima[6].
Il periodo di prova nei contratti a termine dopo il c.d. Decreto Trasparenza e il Collegato Lavoro e la sua interpretazione da parte del Ministero del Lavoro
Come evidenziato, su questo assetto è intervenuto l’art. 7 del D.Lgs. n. 104/2022, così come riformulato per effetto dell’art. 13 del recentissimo Collegato (L. n. 203/2024).
Sebbene anche tale disposizione, nel fissare i parametri in base ai quali proporzionare la durata della prova nei contratti a termine, valorizzi, oltre alla durata del contratto, anche le mansioni da svolgere e la natura dell’impiego, poi, nel predeterminarne delle durate piuttosto brevi e rigide, di fatto sminuisce del tutto la portata effettiva di tali criteri. Ciò in quanto la norma dispone che “fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”.
E ciò vale a maggior ragione alla luce della lettura della disposizione data dal Ministero del lavoro con la circolare richiamata in apertura. Secondo il Ministero, infatti, lo spazio di intervento che, come si legge, la norma demanda alla contrattazione collettiva, in quanto vincolato dal fatto di potersi muovere solo nella direzione del favor praestatoris, implicherebbe che questa potrebbe solo ulteriormente ridurre le durate della prova, già di per sé esigue.
Ora, premesso che, sul piano pratico, in un quadro normativo quale quello attuale, improntato alla facoltà di stipulare, fino al limite dei 12 mesi, contratti a termine acausali, la questione della prova è sostanzialmente risolta mediante l’utilizzo del contratto a tempo determinato stesso anche direttamente ai fini della prova (:non si vede infatti, ad es., che senso abbia inserire in un contratto a tempo determinato di un mese, un periodo di prova di soli 2 giorni, in luogo di utilizzare direttamente il contratto stesso, come più ampio periodo di prova), c’è comunque da chiedersi se la lettura fornita dal Ministero sia l’unica corretta o, seppure negli spazi offerti dalla formulazione normativa, se ne possa trarre anche un’altra, magari anche più coerente con la ratio del periodo di prova e della stessa norma in commento.
Questo è quello che si proverà a fare qui di seguito.
Note critiche alle letture (Ministeriali e non solo) volte a limitare l’intervento della contrattazione collettiva nel senso della sua possibilità di sola riduzione della durata del periodo di prova
Ebbene, v’è innanzi tutto da osservare che se si accetta la lettura ministeriale, secondo la quale l’unica direzione nella quale potrebbe muoversi la contrattazione collettiva, sarebbe nel senso della riduzione della durata della prova, dovrebbe necessariamente concludersi che il Legislatore, con la norma che pone il limite inderogabile dei 15 e dei 30 giorni di sua estensione massima (nei ctd di durata inferiore, rispettivamente, ai 6 e 12 mesi), avrebbe emanato una previsione illogica, in quanto avrebbe fissato dei tetti mai raggiungibili. Tali tetti, infatti, appaiono all’evidenza di per sé irraggiungibili applicando il criterio di calcolo “ordinario legale” di un giorno di effettivo lavoro ogni 15 di calendario (che porta a tetti di 12 e 24 giorni), e lo sarebbero in modo assoluto laddove neanche la contrattazione collettiva, unica legittimata a derogare agli effetti di tale criterio di calcolo, potesse arrivare a raggiungerli. Ciò che appunto accadrebbe qualora come proposto dal Ministero, questa potesse rivederli solo al ribasso.
Dovendosi evidentemente escludere che il Legislatore abbia emanato una disposizione illogica, e dovendosi quindi necessariamente individuare un suo effettivo ambito di operatività, e quindi una sua lettura che, in qualche modo, consenta che quei tetti siano raggiungibili, ecco allora che, diversamente da quanto dai più (e dal Ministero) ipotizzato, la direzione in cui parrebbe potersi logicamente muovere la contrattazione, non può che essere anche quella che va invece verso l’alto, perché è appunto solo così che quei tetti massimi possono diventare raggiungibili, ferma la loro inderogabilità.
In altri termini, è la logica intrinseca della disposizione che impone di ritenere che, coerentemente con la sua formulazione, la direzione che va dai 12 fino ai 15 e dai 24 fino ai 30 giorni, appare, se non addirittura proprio come (l’unica) “obbligata” in ragione della previsione dei tetti di 15 e 30 giorni, comunque sicuramente compatibile con essi.
Vero è che c’è il vincolo per cui le disposizioni della contrattazione devono essere più favorevoli per i lavoratori. Ma, in tale valutazione, si deve tenere conto dell’interesse del lavoratore anche a una durata che sia almeno tale da consentire l’effettività della prova.
Al riguardo pare opportuno ricordare che, come da pacifica e consolidata giurisprudenza formatasi sulla portata dell’art. 2096 c.c., la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono saggiare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, verificando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto[7].
Ora, è evidente che qualsiasi esperimento, perché possa dirsi effettivamente tale, richiede innanzi tutto che lo stesso si svolga per un tempo almeno sufficiente, tale da consentire al datore di lavoro di verificare – e al lavoratore di poter dimostrare –, l’idoneità al lavoro da svolgersi, in ragione di quello che è il suo oggetto.
Non a caso la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 189/1980, affermando l’obbligo delle parti “a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova (art. 2096, secondo comma, c.c.)”, ne ha fatto appunto discendere “un limite alla discrezionalità dell’imprenditore, nel senso che la legittimità del licenziamento da lui intimato durante il periodo di prova può efficacemente essere contestato dal lavoratore quando risulti che non è stata consentita, tra l’altro, per la inadeguatezza della durata dell’esperimento … quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato”. Ed anche nella giurisprudenza ordinaria si è osservato come l’esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consente alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. Pertanto, non è configurabile un esito negativo della prova, e l’eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità “ad nutum” del rapporto di lavoro in prova, qualora la durata dell’esperimento non risulti adeguata ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova, sul quale incombe il relativo onere probatorio[8].
In questa prospettiva, nel patto di prova, a fianco ad una esigenza di sua durata massima, emerge anche una esigenza di sua durata minima. Ed anzi, è soprattutto questa ad essere connaturata alla funzione del periodo di prova, nella misura in cui, appunto, è quella minima necessaria affinché, entrambe le parti, e quindi anche il lavoratore, abbiano a disposizione un tempo sufficiente a quella verifica e a quella dimostrazione che ne costituisce la causa.
Ne consegue, a mio avviso, che la questione della eventuale sfavorevolezza della durata della prova, coerentemente peraltro anche con la necessità di rispetto degli altri parametri fissati dall’art. 7 in commento (mansioni e natura dell’impiego), può porsi solo allorquando si superi la soglia di durata minima indispensabile affinché una prova possa dirsi effettivamente tale. Anzi, al di sotto di questa soglia minima, parrebbe porsi proprio un problema di validità della clausola per mancanza di causa (ex artt. 1325 e 1418 c.c.). Soglia che, vista la esiguità dei termini previsti dalla disposizione in commento, é quanto meno dubbio sia superata, negli stretti spazi rimessi alla contrattazione anche qualora rivolta ad ampiarne la durata. Anzi, nella maggior parte dei casi, parrebbe comunque porsi ben al di sotto di quella minima indispensabile, almeno con riguardo alle mansioni di maggiore complessità.
Onde, a mio avviso un eventuale un innalzamento della sua durata da parte della contrattazione, fermo il limite inderogabile dei 15 e 30 giorni, apparirebbe comunque rientrante nel novero delle disposizioni più favorevoli al lavoratore.
Peraltro, proprio perché in questo caso la prova si innesta in un contratto a termine, la maggiore durata può essere più favorevole per il lavoratore, in quanto gli offre anche uno spazio più ampio per eventualmente liberarsi dal rapporto prima di esporsi al rischio derivante da eventuali dimissioni ante tempus, che potrebbero potenzialmente essere molto più onerose di quelle ad nutum con preavviso dal rapporto a tempo determinato.
Si aggiunga un ultimo dato. Nel fornire la sua lettura, il Ministero non tiene conto anche di un altro elemento.
Come già ricordato sopra, nel nostro ordinamento, con riguardo ai rapporti di lavoro a cui si applica la Legge n. 604/1966, ed in particolare il suo art. 10 cit. (:il discorso si pone in termini diversi per quelli a cui si applica il D.Lgs. n. 23/2015, laddove manca una norma analoga, ma qui, per ragioni di spazio e di tempo non c’è la possibilità di parlarne), la durata massima (di sei mesi) del periodo di prova rappresenta anche e soprattutto un limite all’operatività della disciplina sui licenziamenti. Nel senso che decorso il periodo di sei mesi o il diverso periodo previsto dalla contrattazione collettiva operano tutti i vincoli al recesso imposti al datore di lavoro
Di contro, nel nostro ordinamento non è previsto alcun vincolo alla facoltà di dimissioni.
Con ciò si vuole dire che la contrattazione collettiva potrebbe innalzare il periodo di prova anche al fine di estendere la facoltà di dimissioni ad nutum del solo lavoratore. Ciò che pure, sebbene implichi un innalzamento del periodo di prova, ciononostante costituirebbe una condizione assolutamente coerente col principio del favor, posto che estende il periodo in cui esonera il lavoratore dal preavviso o dal pagamento della relativa indennità.
Conclusivamente, a mio avviso non è condivisibile l’affermazione secondo cui l’intervento della contrattazione collettiva in materia, possa muoversi solo nel senso di ridurre la durata del periodo di prova. In quanto, come si è provato a dimostrare, vi possono essere anche casi in cui il relativo innalzamento corrisponde ad un interesse del lavoratore, ed appare soprattutto coerente con la causa del patto che, in caso di periodo troppo breve, apparirebbe difficilmente configurabile (questa volta per eccessiva sua brevità).
[1] In generale sul patto di prova, E. Calabrò, Periodo di prova (dir. priv.), in Enc. dir., XXXIII, 70 e ss.; P. A. Varesi, Le Assunzioni. Prova e termine nei rapporti di lavoro. Artt. 2096-2097, in P. A. Varesi, M. Roccella (a cura di), P. Schlesinger (diretto da), Il Codice civile. Commentario, 1990; R. Del Punta, Lavoro in prova, in Enc. giur., XX; P. A. Varesi, Prova (Patto di), in Dig., Sez. Comm., 1995, 423 e ss.; R. Franci, Il patto di prova nei suoi aspetti più rilevanti, in LPO, 2002, 11, 1217 e ss. Per la dottrina più recente si rinvia a quella citata nel contributo di W. Chiaromonte citato nella nota 7.
[2] Cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22758.
[3] La disposizione XX della Carta del lavoro, subordinava infatti la pubblicazione dei contratti corporativi al fatto che prevedessero un periodo di prova.
[4] Tra le tante, Trib. Udine, Sez. Lav., 20 febbraio 2023, n.218.
[5] P. A. Varesi, Prova (Patto di), op. cit., 428.
[6] Emblematica in tal senso la decisione n. 253/2021 della Corte d’Appello di Firenze che, con riguardo appunto alla disciplina antecedente al D.Lgs. n. 104/2022, ha affermato che “Ai fini della legittimità del patto di prova devono sussistere i seguenti requisiti: il patto deve avere forma scritta, antecedente o contestuale alla costituzione del rapporto di lavoro; deve avere durata compresa entro il periodo massimo stabilito dalla legge o dal contratto collettivo in relazione alla categoria e al livello di inquadramento del lavoratore; deve essere svolto in maniera effettiva. Queste condizioni operano anche al periodo di prova di un contratto a termine, con la precisazione che, in questo caso, si deve tenere in considerazione la durata complessiva del contratto di lavoro. Tuttavia manca nel nostro ordinamento una regola per stabilire la durata adeguata del periodo di prova nel contratto a termine: in teoria tale lacuna potrebbe essere colmata dalla contrattazione collettiva, prevedendo una durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato. Ad ogni modo tale lacuna comporta che, in assenza di specifiche indicazioni, il patto di prova non è nullo se non abbia superato il termine massimo previsto dalla contrattazione collettiva”.
[7] Cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Lav., 09 marzo 2020, n. 6633, in Riv. it. dir. lav., 2020, 3, 454, con nota di W. Chiaromonte, Ritenta, (non) sarai più fortunato! L’illegittimità per difetto di causa dell’apposizione del patto di prova a contratti successivi, a cui si rinvia anche per i riferimenti alla dottrina più recente. Più in generale sul patto di prova, E. Calabrò, op. cit., 70 e ss.; P. A. Varesi, Le Assunzioni. Prova …., op. cit.; R. Del Punta, op. cit.; P. A. Varesi, Patto di prova, op. cit., 423 e ss.; R. Franci, op. cit., 1217 e ss.
[8] Cass. civ., Sez. Lav., 13 settembre 2006, n. 19558.